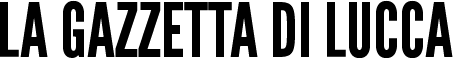Tutto questo gran scrivere e parlare e sparlare del coronavirus, tutti questi grandi dibattiti mediatici tra negazionisti, minimalisti, complottisti, allarmisti, tutto questo bombardamento mediatico su nuovi casi, su un numero sempre maggiore di persone in isolamento, sulla crisi economica che incombe sui paesi maggiormente colpiti, tra cui – purtroppo – l’Italia, ha riportato alla mia memoria i Promessi Sposi del Manzoni, in particolare il capitolo 31 che descrive l’arrivo dell’epidemia di peste che colpì Milano nel 1629.
Senza voler contribuire all’imperante allarmismo e senza assolutamente voler paragonare il coronavirus alla peste, ho per l’appunto trovato di estrema attualità come Manzoni descrivesse l’arrivo della peste a Milano nel 1629: una narrazione delle reazioni vissute dalla gente più di 300 anni fa - l’incredulità iniziale e la sottovalutazione del problema dovuta anche alla sporadicità dei primi casi, per poi passare al negazionismo voluto, agli attacchi a quei pochi medici che invece avevano ben inquadrato la gravità del problema, per poi arrivare alle tardive quantomai inutili misure prese dai governanti di allora - che sembrano le cronache quotidiane dei nostri giorni.
Così, per un mero esercizio intellettuale - mi sono divertita a richiamare i passi più interessanti e più calzanti di quel capitolo, che riporto sotto a beneficio di chi, fra i lettori, vorrà soffermarsi a leggere e potrà riconoscere nei lanzichenecchi i cinesi, potrà osservare come venne trattato il Burioni dell’epoca, potrà ritrovare le stesse (!) misure di isolamento che vennero adottate quando il fenomeno venne inquadrato per quel che era veramente con le relative conseguenze anche economiche.
In questa analisi dilettantistica e senza pretesa alcuna, voglio però partire dalla fine del capitolo 31, riportando l’osservazione di Manzoni che tutti dovrebbero far propria:
“Si potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, quel corso così lungo e così storto, prendendo il metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare.
Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, dico noi uomini in generale, siamo un po’ da compatire”.
E allora leggiamo alcuni brani del capitolo 31 dei Promessi Sposi, partendo dall’arrivo della peste a Milano:
“La peste che il tribunale della sanità aveva temuto che potesse entrar con le bande alemanne nel milanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è noto parimente che non si fermò qui, ma invase e spopolò una buona parte d’Italia.
Per tutta adunque la striscia di territorio percorsa dall’esercito, s’era trovato qualche cadavere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali violenti, strani, con segni sconosciuti alla più parte de’viventi. C’era soltanto alcuni a cui non riuscissero nuovi: que’ pochi che potessero ricordarsi della peste che, cinquantatré anni avanti, aveva desolata pure una buona parte d’Italia, e in ispecie il milanese, dove fu chiamata, ed è tuttora, la peste di san Carlo (e qui il pensiero va alla famosa influenza/flagello del secolo scorso chiamata la spagnola a cui il coronavirus è stato da alcuni paragonato).
“Il protofisico Lodovico Settala, che, non solo aveva veduta quella peste, ma n’era stato uno de’ più attivi e intrepidi, e, quantunque allor giovinissimo, de’ più riputati curatori; e che ora, in gran sospetto di questa, stava all’erta e sull’informazioni, riferì, il 20 d’ottobre, nel tribunale della sanità, come, nella terra di Chiuso (l’ultima del territorio di Lecco, e confinante col bergamasco), era scoppiato indubitabilmente il contagio. Non fu per questo presa veruna risoluzione, come si ha dal Ragguaglio del Tadino.
Ed ecco sopraggiungere avvisi somiglianti da Lecco e da Bellano.
Il tribunale allora si risolvette e si contentò di spedire un commissario che, strada facendo, prendesse un medico a Como, e si portasse con lui a visitare i luoghi indicati. Tutt’e due, “o per ignoranza o per altro, si lasciorno persuadere da un vecchio et ignorante barbiero di Bellano, che quella sorte de mali non era Peste” ma, in alcuni luoghi, effetto consueto dell’emanazioni autunnali delle paludi, e negli altri, effetto de’ disagi e degli strapazzi sofferti, nel passaggio degli alemanni.
Una tale assicurazione fu riportata al tribunale, il quale pare che ne mettesse il cuore in pace.
Ma arrivando senza posa altre e altre notizie di morte da diverse parti, furono spediti due delegati a vedere e a provvedere: il Tadino suddetto, e un auditore del tribunale. Quando questi giunsero, il male s’era già tanto dilatato, che le prove si offrivano, senza che bisognasse andarne in cerca.
S’informarono del numero de’ morti: era spaventevole; visitarono infermi e cadaveri, e per tutto trovarono le brutte e terribili marche della pestilenza.
Diedero subito, per lettere, quelle sinistre nuove al tribunale della sanità, il quale, al riceverle, che fu il 30 d’ottobre, si dispose, dice il medesimo Tadino, “a prescriver le bullette, per chiuder fuori dalla Città le persone provenienti da’ paesi dove il contagio s’era manifestato” (e qui il paragone con l’ordine di chiusura dei voli provenienti dalla Cina emesso dal Governo italiano prima e con il totale isolamento dei pesi focolaio poi è evidente).
… “Intanto i delegati presero in fretta e in furia quelle misure che parver loro migliori; e se ne tornarono, con la trista persuasione che non sarebbero bastate a rimediare e a fermare un male già tanto avanzato e diffuso”.
Poi il Manzoni descrive - incredulo - la reazione della gente che, seppur viveva in luoghi più o meno vicini alle città già infette, non voleva riconoscere l’epidemia in corso, negando l’evidenza (e qui vengono in mente i tanti “ma tanto da noi non arriva” sentiti spesso in giro ai giorni nostri e non solo al bar dello sport):
“…ciò che fa nascere un’altra e più forte maraviglia, è la condotta della popolazione medesima, di quella, voglio dire, che, non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ragion di temerlo. All’arrivo di quelle nuove de’paesi che n’erano così malamente imbrattati, di paesi che formano intorno alla città quasi un semicircolo, in alcuni punti distante da essa non più di diciotto o venti miglia; chi non crederebbe che vi si suscitasse un movimento generale, un desiderio di precauzioni bene o male intese, almeno una sterile inquietudine?
Eppure, se in qualche cosa le memorie di quel tempo vanno d’accordo, è nell’attestare che non ne fu nulla. La penuria dell’anno antecedente, le angherie della soldatesca, le afflizioni d’animo, parvero più che bastanti a render ragione della mortalità: sulle piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là una parola del pericolo, chi motivasse peste, veniva accolto con beffe incredule, con disprezzo iracondo. La medesima miscredenza, la medesima, per dir meglio, cecità e fissazione prevaleva nel senato, nel Consiglio de’ decurioni, in ogni magistrato”.
Il Manzoni narra poi il comportamento adottato allora dalla Chiesa, mentre oggi in alcune diocesi è stato sospeso lo scambio della pace a Messa e pare che in alcune chiese le acquasantiere siano state svuotate, per precauzione.
“Trovo che il cardinal Federigo, appena si riseppero i primi casi di mal contagioso, prescrisse, con lettera pastorale a’ parrochi, tra le altre cose, che ammonissero più e più volte i popoli dell’importanza e dell’obbligo stretto di rivelare ogni simile accidente, e di consegnar le robe infette o sospette”.
Una volta individuato in un soldato il presunto “caso zero”, il Manzoni descrive poi le misure adottate per contenere il contagio: “Il tribunale della sanità fece segregare e sequestrare in casa la di lui famiglia; i suoi vestiti e il letto in cui era stato allo spedale, furon bruciati. Due serventi che l’avevano avuto in cura, e un buon frate che l’aveva assistito, caddero anch’essi ammalati in pochi giorni, tutt’e tre di peste. Il dubbio che in quel luogo s’era avuto, fin da principio, della natura del male, e le cautele usate in conseguenza, fecero sì che il contagio non vi si propagasse di più.
Ma il soldato ne aveva lasciato di fuori un seminìo che non tardò a germogliare. Il primo a cui s’attaccò, fu il padrone della casa dove quello aveva alloggiato, un Carlo Colonna sonator di liuto. Allora tutti i pigionali di quella casa furono, d’ordine della Sanità, condotti al lazzeretto, dove la più parte s’ammalarono; alcuni morirono, dopo poco tempo, di manifesto contagio.
Nella città, quello che già c’era stato disseminato da costoro, da’ loro panni, da’ loro mobili trafugati da parenti, da pigionali, da persone di servizio, alle ricerche e al fuoco prescritto dal tribunale, e di più quello che c’entrava di nuovo, per l’imperfezion degli editti, per la trascuranza nell’eseguirli, e per la destrezza nell’eluderli, andò covando e serpendo lentamente, tutto il restante dell’anno, e ne’ primi mesi del susseguente 1630”.
“Di quando in quando, ora in questo, ora in quel quartiere, a qualcheduno s’attaccava, qualcheduno ne moriva: e la radezza stessa de’casi allontanava il sospetto della verità, confermava sempre più il pubblico in quella stupida e micidiale fiducia che non ci fosse peste, nè ci fosse stata neppure un momento. Molti medici ancora, facendo eco alla voce del popolo (era, anche in questo caso, voce di Dio?), deridevan gli augùri sinistri, gli avvertimenti minacciosi de’ pochi; e avevan pronti nomi di malattie comuni (e qui il pensiero va a chi uguaglia il nuovo virus alle più banali influenze), per qualificare ogni caso di peste che fossero chiamati a curare; con qualunque sintomo, con qualunque segno fosse comparso.
Gli avvisi di questi accidenti, quando pur pervenivano alla Sanità, ci pervenivano tardi per lo più e incerti”.
Poi Manzoni descrive la paura di coloro che temevano di finire al lazzaretto ( oggi quante volte si sente dire: “ah io se mi ammalo non lo dico certo, non voglio mica finire in quarantena”?).
“Il terrore della contumacia e del lazzeretto aguzzava tutti gl’ingegni: non si denunziavan gli ammalati, si corrompevano i becchini e i loro soprintendenti; da subalterni del tribunale stesso, deputati da esso a visitare i cadaveri, s’ebbero, con danari, falsi attestati”.
Siccome però, a ogni scoperta che gli riuscisse fare, il tribunale ordinava di bruciar robe, metteva in sequestro case, mandava famiglie al lazzeretto, così è facile argomentare quanta dovesse essere contro di esso l’ira e la mormorazione del pubblico, “della Nobiltà, delli Mercanti et della plebe, ” dice il Tadino; persuasi, com’eran tutti, che fossero vessazioni senza motivo, e senza costrutto.
L’odio principale cadeva sui due medici; il suddetto Tadino, e Senatore Settala, figlio del protofisico: a tal segno, che ormai non potevano attraversar le piazze senza essere assaliti da parolacce, quando non eran sassi. (come non pensare ai “sassi mediatici”, agli insulti e alle accuse rivolte al noto virologo Burioni quando invitava – rivolgendosi anche ai suoi colleghi - di non sottovalutare il nuovo virus?)
… “Ma sul finire del mese di marzo, cominciarono, prima nel borgo di porta orientale, poi in ogni quartiere della città, a farsi frequenti le malattie, le morti, con accidenti strani di spasimi, di palpitazioni, di letargo, di delirio, con quelle insegne funeste di lividi e di bubboni; morti per lo più celeri, violente, non di rado repentine, senza alcun indizio antecedente di malattia.
I medici opposti alla opinion del contagio, non volendo ora confessare ciò che avevan deriso, e dovendo pur dare un nome generico alla nuova malattia, divenuta troppo comune e troppo palese per andarne senza, trovarono quello di febbri maligne, di febbri pestilenti: miserabile transazione, anzi trufferia di parole, e che pur faceva gran danno; perchè, figurando di riconoscere la verità, riusciva ancora a non lasciar credere ciò che più importava di credere, di vedere, che il male s’attaccava per mezzo del contatto.
I magistrati, come chi si risente da un profondo sonno, principiarono a dare un po’ più orecchio agli avvisi, alle proposte della Sanità, a far eseguire i suoi editti, i sequestri ordinati, le quarantene prescritte da quel tribunale”.
Ed ecco poi il Manzoni descrivere le difficoltà nel reperire le risorse economiche per tutte le zone colpite dall’epidemia, per sopperire alla disoccupazione che si era creata e di come sostenere coloro che non avevano più il lavoro a causa della peste e di come rifornire i vari paesi prima che rimanessero isolati perché la peste era giunta anche lì.
“…Chiedeva esso di continuo anche danari per supplire alle spese giornaliere, crescenti, del lazzeretto, di tanti altri servizi; e li chiedeva ai decurioni, intanto che fosse se tali spese toccassero alla città, o all’erario regio. Ai decurioni faceva pure istanza il gran cancelliere, per ordine anche del governatore, ch’era andato di nuovo a metter l’assedio a quel povero Casale; faceva istanza il senato, perchè pensassero alla maniera di vettovagliar la città, prima che dilatandovisi per isventura il contagio, le venisse negato pratica dagli altri paesi; perchè trovassero il mezzo di mantenere una gran parte della popolazione, a cui eran mancati i lavori”.
“Anche nel pubblico, quella caparbietà di negar la peste andava naturalmente cedendo e perdendosi, di mano in mano che il morbo si diffondeva, e si diffondeva per via del contatto e della pratica; e tanto più quando, dopo esser qualche tempo rimasto solamente tra’ poveri, cominciò a toccar persone più conosciute.
C’era, del resto, un certo numero di persone non ancora persuase che questa peste ci fosse. E perché, tanto nel lazzeretto, come per la città, alcuni pur ne guarivano, “si diceua ” (gli ultimi argomenti d’una opinione battuta dall’evidenza son sempre curiosi a sapersi), “ si diceua dalla plebe, et ancora da molti medici partiali, non essere vera peste, perché tutti sarebbero morti.”
“In principio dunque, non peste, assolutamente no, per nessun conto: proibito anche di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del malefizio, la quale altera e confonde l’idea espressa dalla parola che non si può più mandare indietro”.
Dunque, lungi qualunque inappropriato paragone tra questa epidemia e quella del 1620, prima di parlare è bene fare come suggeriva Manzoni: pensare, osservare, paragonare, per non rischiare che al primo starnuto o colpo di tosse in un luogo pubblico arrivi un monatto, preceduto dal suono di un campanello, a trascinarci in un lazzaretto, pardon in un idoneo luogo di quarantena.