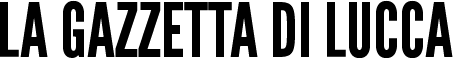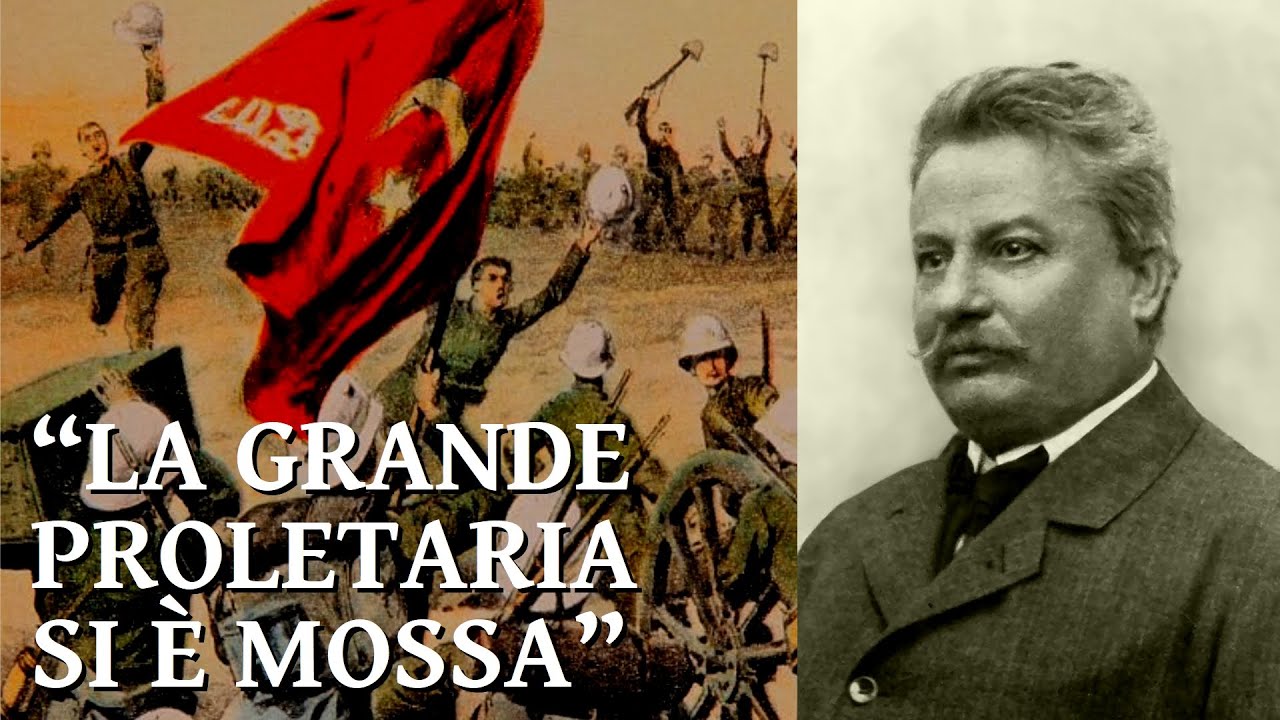L'impresa di Libia
Il discorso che Giovanni Pascoli tenne al Teatro Comunale di Barga il 21 novembre 1911 ci appare piuttosto sbilanciato in senso colonialista e bellicista: infatti, trasuda disprezzo per gli arabi al limite del razzismo e si connota per una retorica iper patriottica profusa a piene mani.
Risulta sconcertante, forse oggi più di allora, che il poeta della natura, il cantore delle piccole cose, del dolore e dei sentimenti semplici e umani, abbia sentito la necessità di gonfiare il petto e i muscoli e alzare la voce per esaltare un’avventura militare di pretto stampo colonialista. Si trattò di un’occupazione preparata da un’azione diplomatica avviata dal nostro Paese fin dal 1887, con l’accordo italo-tedesco, aggiunto al secondo trattato della Triplice Alleanza e proseguito negli anni successivi con una serie di accordi con Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Russia.
Lo sfacelo dell’Impero ottomano e l’occupazione del Marocco, attuata dalla Francia, spinsero il governo Giolitti a decidere per la guerra con l’appoggio del re e scavalcando il Parlamento. Forti pressioni in favore di quell’impresa vennero dai fronti più diversi: il Banco di Roma che aveva investito in numerose attività economiche nel bacino del Mediterraneo e in Libia, contando sulla sua trasformazione in colonia; la stampa cattolica moderata che vide nella guerra l’occasione per conciliare cattolicesimo e patriottismo e si unì alla campagna di stampa bellicista promossa dai nazionalisti, anche con la diffusione di false notizie sulle presunte prospettive di ricchezza offerte da quei territori ai lavoratori italiani. Appoggiò l’impresa anche il quotidiano più rappresentativo della borghesia italiana, “Il Corriere della Sera”, fino a quel momento ostile alla politica di Giolitti, a capo del governo più a sinistra della breve storia d’Italia: sulle sue pagine D’Annunzio celebrò l’impresa nelle dieci Canzoni delle gesta d’oltremare.
Socialisti titubanti
Anche il movimento socialista nei confronti di questa vicenda manifestò non poche incertezze e contraddizioni.
A favore della guerra si dichiararono i sindacalisti rivoluzionari, che vedevano nel colonialismo una fase necessaria dello sviluppo capitalistico, e non pochi simpatizzanti di quella impresa che si trovavano sulla destra riformista del Psi. Fu alla fine dell'estate del 1911 che si consumarono i prodromi di quella guerra che Giolitti, presidente del Consiglio, di solito molto misurato, non esitò a definire “una fatalità storica”.
Uno sciopero generale contro la guerra in Libia, deciso il 25 settembre nel corso di una riunione congiunta tra Psi e Cgdl, ottenne un successo solo parziale che non sarà seguito da altre iniziative di rilievo, anche a causa di difficoltà interne al partito e al sindacato.
Le agitazioni più violente contro la guerra si ebbero in Romagna, proprio la terra d’origine del Pascoli, sotto la guida di Benito Mussolini e del giovane repubblicano Pietro Nenni.
Una vicenda, quella della Libia, che mette in movimento passioni di parte, logora il sistema di potere giolittiano, provoca contraccolpi politici, scatena emozioni. Due fatti: al congresso del Psi, il 12 ottobre 1911, proprio sulla guerra di Libia si arresta la marcia di avvicinamento dei socialisti al governo e al programma di Giolitti; Ivanoe Bonomi e Leonida Bissolati, riformisti di destra che scelgono di continuare a sostenere il presidente del Consiglio in contrasto con le direttive del partito, saranno costretti a lasciarlo nel luglio del 1912.
La guerra sul campo
Il corpo di di spedizione italiano - 30.000 uomini, saliti poi a 103.000 agli ordini del generale Carlo Caneva - sbarcato l’11 ottobre 1911 a Tripoli occupa i principali centri libici, ma deve fare i conti con un’inaspettata resistenza: già il 23 ottobre un attacco turco, che puntava a riconquistare la città di Tripoli appena caduta in mani italiane, provoca a Sciara Sciatt quasi 400 morti tra i bersaglieri italiani.
Mentre un’ondata di commozione percorre il Paese, in Libia una feroce repressione intrapresa dai militari italiani, segnerà quella, prima, palese battuta d’arresto militare che richiama i fantasmi di Dogali e di Adua.
Ed è proprio a questo punto che s’inserisce l’intervento del Pascoli, così complesso, così commosso, così carico di ambigua generosità: a partire dal ricavato di quel discorso di Barga, destinato alle famiglie dei militari morti e dei feriti nella avanzata di Ain Zara, che avveniva proprio in quei giorni, mentre la stampa internazionale criticava unanimemente le durezze delle rappresaglie attuate dopo Sciara Sciat dalle truppe italiane contro la popolazione civile.
Da una sensazione di isolamento internazionale, figlio dell’incomprensione e della minorità in cui l’Europa sembrava relegare spesso il nostro Paese, quindi da un senso di inferiorità e frustrazione, nasce questo intervento pascoliano solenne e polemico, esortativo e appassionato in cui il Poeta fa riferimento a due temi di sicuro effetto presso la pubblica opinione: l’emigrazione e la recente memoria risorgimentale al termine dell’anno che aveva visto a Torino una sorta di Expo patriottico tricolore per il primo mezzo secolo di unità d’Italia. Un argomento, poi, quello della faticosa ricerca di lavoro e pane all’estero, molto sentito da generazioni d’italiani poveri, e segnatamente dai lucchesi, disseminati in tutti i continenti del pianeta alla ricerca di quell'esistenza più degna di essere vissuta che non riuscivano a realizzare nella loro patria.