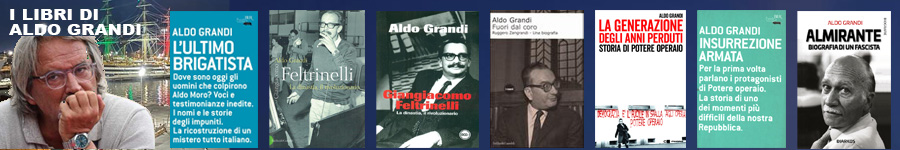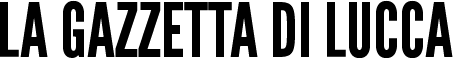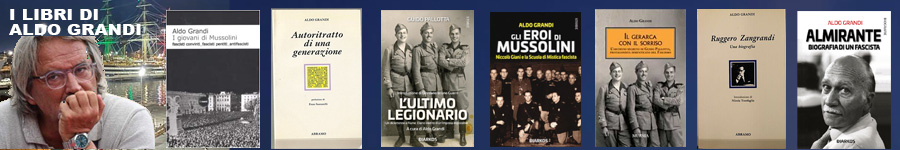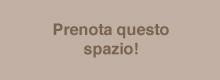Dieci anni fa esalava l'ultimo respiro il mio amico Enrico Nori di anni 80, che tanto mi insegnò nell'arte della scrittura in sintesi, scevra dalla retorica o da toni aulici. Enrico è stato forse il primo, ma, indubbiamente, il più capace "Ghost Writer" d'Italia. Famosi capitani d'industra quali Gianni Agnelli, Cesare Romiti, Pininfarina ed altri sono stati suoi clienti soddisfatti.
"Non ho scritto discorsi solo per il Papa – ammetteva Nori – ma non è detta l'ultima parola". Enrico Nori era uomo coltissimo dal fascino e stile "Napoleonico" che diceva le verità, anche sgradevoli, in faccia a tutti. Forse per questo non erano pochi a giudicarlo un essere superbo, quasi inavvicinabile e quasi da odiare.
Nel 1994 Lui, primo epigono della miglior borghesia locale e ritenuto l'anarchico della Fiat di Torino si candida a sindaco di Carrara, città dominata dalle sinistre, in una lista detta "Forza Carrara" che annoverava partiti di destra. Nori va al ballottaggio e perde l'elezione per poco. Ma Lui, come nella vita sempre aveva fatto, non si dette il voto.
"Sono andato a passeggiare al mare – disse a tutti i giornali – col mio cane che di nome si chiama Gimmi".
Rammento che Enrico mi confidò che Gianni Agnelli circa otto mesi prima di morire, lo fece chiamare invitandolo a colazione a Villar Perosa.
"L'Avvocato voleva solo parlare – mi disse Nori – parlare del passato, della Fiat, del mio gran litigio con suo fratello Umberto, della morte violenta e prematura di suo figlio Edoardo e della sua salute cagionevole. "Caro Nori -ammise Agnelli - io dovrei spostarmi sulla carrozzina, afflitto da dolori lancinanti che non mi lasciano tregua. Tutti i medici mi dicono e mi propongono carrozzine per tutti i gusti. Ma sa perché non siedo in carrozzina a rotelle ? Perché ne avrei vergogna!" concluse il grande Avvocato...
La sua paziente consorte Marisa Massaia sta ancora nella casa di Avenza, circondata da oggetti, libri, immagini e ricordi di tempi felici, tra magnifici "Ex Voto" tanto cari al marito. "Il mio Enrico è qui – ammette Marisa – eccolo che ondeggia come al solito sulla antica sedia a dondolo. Il mio brontolone ascolta solo musica classica ed i Beatles. Poi la Signora Nori sorride e conclude: "Se vuoi te lo saluto". A Lei il mio proemio in ricordo di Enrico è dedicato.
"GIOCHI DI PAROLE". MEMORIE DI UNO SCRITTORE PER CONTO TERZI.
di Enrico Nori
Oggi, se qualcuno mi chiede ancora della mia attività rispondo con un rassegnato, ma liberatorio... "pensionato". Ieri, la domanda mi precipitava nell'imbarazzo. Consulente? Troppo vago. Speech writer, ghost writer? Troppo complicato. Avrei voluto dire "scrittore per conto terzi". Specchio ironico del mio improbabile mestiere. Per anni, ho scritto sotto molti pseudonimi; alcuni noti, altri meno. I miei clienti sono stati industriali, politici, soci del Rotary club, persino un prete. I nomi non voglio farli. Sarebbe una inutile caduta di gusto. Non sono uno storico e neppure un vanesio pettegolo. Ho avuto una gioventù molto lunga. Sono riuscito a farla durare sino a 33 anni. Lontano da studi regolari e dal lavoro.
Vivendo la vita, divorandola, sentendola con tutti i pori. Credevo potesse durare per sempre. Invece, i denti cominciarono a ballare, i capelli a cadere. Le stagioni non erano più le stesse, il mare era più opaco, le donne meno disponibili. Bisognava provare a lavorare. La catena delle raccomandazioni e delle conoscenze mi portò, nella metà degli anni '60, all'Unione Industriale di Torino. Fu lì che conobbi i "Giovani industriali" i quali, con spirito innovativo, spingevano per la riforma della loro organizzazione.
Entrai in assonanza con le giovanili voglie di cambiamento. Così, nel 1969, fui chiamato a fare l'assistente della Commissione Pirelli, incaricata di modificare lo Statuto della Confindustria.
Undici industriali, grandi, medi e piccoli, si riunivano una volta la settimana all'ultimo piano del grattacielo Pirelli. Eravamo alla vigilia dell'autunno caldo. Per le strade, sciamavano cortei al grido "Agnelli, Pirelli, Colombo le piogge d'autunno saranno di piombo". La Commissione elaborò organigrammi su organigrammi, sfuggendo al problema del ruolo dell'imprenditore. La parola "profitto" era considerata impronunciabile dati i tempi. Per dare legittimazione a quella che sembrava una bestemmia, fu coniata la perifrasi "il profitto è la misura dell'efficienza".
Raggiunto l'accordo sulla nuova forma organizzativa della Confindustria, si presentò il problema del documento di accompagnamento. Che doveva essere una riflessione degli imprenditori sul loro ruolo e sul modello di società che volevano. Scoprii, così, che gli industriali erano certo capaci di riflettere, ma delegavano ad altri il compito di scrivere. Il cosiddetto Rapporto Pirelli ha avuto, nel tempo, padri legittimi e padri abusivi. Ritengo di essere stato, assieme a Ubaldo Scassellati, già allora direttore della Fondazione Agnelli, fra i padri legittimi. Riletto a più di 30 anni di distanza, il Rapporto Pirelli mostra tutte le crepe prodotte dal tempo. Ma non si può negare che sia stato l'unico documento in cui la classe imprenditoriale si impegna in una seria riflessione su se stessa.
Il fatto che, poi, non siano stati imprenditori a scriverlo fa parte delle regole del gioco. Terminata la Commissione Pirelli, divenne quasi naturale che finissi a lavorare con Scassellati nella direzione della Fondazione Agnelli. Ebbi modo di apprezzare l'intelligenza dell'uomo, tagliente come un laser. Ne dovetti anche subire i lampi di devastante paranoia.
La Fondazione dei primi anni settanta ebbe il merito di affrontare in modo nuovo - sia pure fra nevrosi, confusioni e megalomanie - alcuni dei problemi che sarebbero diventati centrali nell'Italia del domani. Su tutto questo è sceso l'oblio, l'unica cosa che si ricorda di quel periodo è la vicenda del "5x5". Ne fui felicemente estraneo allora; in seguito, provai a farmelo spiegare senza capire. Credo che tutto si riducesse all'innocua esercitazione di alcuni intellettuali frustrati e voyeur di una politica a cui non avevano mai partecipato. Essi partorirono uno schema, con vaga assonanza massonica, di scomposizione della realtà per funzioni. Sullo sfondo aleggiava la proposta di riforme istituzionali che aveva per riferimento la Francia di De Gaulle e guardava a Fanfani come omologo italiano. E' chiaro che i personaggi avevano stature diverse. Ma l'Italia di allora era percorsa dalla psicosi del colpo di stato.
"Panorama" pubblicò una serie di articoli sul "5x5", in bilico fra l'invenzione e la farsa. Si parlava, come adepta della presunta congiura, anche di una donna che vedeva la Madonna. Fu un linciaggio. Solo il vecchio Ferruccio Parri difese la Fondazione denunziando il pozzo di assurdità. Il "5x5" fu poi archiviato. Scassellati emigrò in altre province dell'impero Fiat; la Fondazione cambiò pelle.
Io me ne andai, prima che mi cacciassero; portandomi dietro molte cose che non avevo capito. Tornai, da disoccupato, a casa. A ricercare stagioni e sensazioni che non c'erano più. Fu la noia a riportarmi a Torino. E, ancora una volta, fu un lavoro a trovare me, non io a cercare il lavoro. In Fiat cercavano qualcuno che scrivesse discorsi, sembra non li volesse o non li sapesse fare nessuno. Provarono con Nori, disponibile, ma guardato con diffidenza. Pensavo che si trattasse di un passeggero espediente di sopravvivenza. Si rivelò un mestiere che avrei fatto, a tempo pieno, per molti anni.
Nessuno mi aveva spiegato come si confeziona un discorso. Allora non esistevano testi o corsi per imparare. Mi affidai all'istinto e ricordai di avere letto Norme per la redazione di un testo radiofonico di Carlo Emilio Gadda. Incredibilmente, il grande dinamitardo della nostra lingua, quando era funzionario della Rai, aveva scritto una ineccepibile guida del parlare a un pubblico. Anche se, in questo caso, il pubblico era invisibile. Fu Gadda a farmi capire cosa non dovesse essere un discorso, partendo da una banale constatazione. In un testo scritto per essere letto, chi non capisce può tornare indietro, provare a rileggere. In un testo fatto per essere detto, non è possibile. La conseguenza è la necessità di una estrema chiarezza. Significa abolire le frasi troppo lunghe, che si ripiegano su se stesse mentre chi ascolta smarrisce il soggetto. Significa anche sfrondare la lingua italiana da tutta quella retorica, da tutto quel barocco fiammeggiante che l'appesantisce. Le lingue anglosassoni sono molto più sobrie. Forse perché non hanno subito l'influsso di Benedetto Croce e di Antonio Gramsci.
Non dimenticherò mai le facce stravolte di traduttori che non riuscivano a rendere in inglese quello che diceva un oratore italiano. A fianco delle "convergenze parallele" non possiamo non mettere le contorsioni verbali dei proclami stilati dai terroristi. La ricerca della massima chiarezza mi portò a considerare il discorso un processo di sintesi, non di analisi. Si fanno delle affermazioni, non si percorrono tutti i passaggi con cui ci si arriva.
Sintesi vuol dire brevità, il discorso è un lavoro di sottrazione non di accumulo. Gli americani, che certe cose sono abituati a studiarle, hanno stabilito che l'attenzione di un ascoltatore resta molto alta nel primo quarto d'ora. Poi, comincia a scemare, indipendentemente da cosa ascolta. Per dire una normale cartella dattiloscritta servono due minuti. Il discorso ideale non dovrebbe essere più lungo di sette-otto cartelle. Vecchio al ponte, il racconto di Hemingway, è molto più corto. Eppure, dentro c'è tutto quello che significa una guerra. Se queste sono, a mio avviso, alcune modalità per scrivere un discorso, occorre anche aggiungere la capacità di comportarsi come un sarto: che taglia il vestito a seconda delle misure del cliente. E' un qualcosa che non si può imparare, che affonda nella sensibilità. E' una delle caratteristiche fondamentali che definiscono un buon scrittore per conto terzi.
Il discorso, naturalmente, è fatto di contenuti, oltre che di forma. Chiedere al cliente di turno cosa ha intenzione di dire è una imperdonabile ingenuità. Quando la commisi, mi sentii rispondere: "Se lo sapessi non avrei chiamato lei". Magari, non era vero: ma, quando ci si può permettere un consulente, la pigrizia diventa una tentazione irresistibile. Specie quando si ha altro da fare. Sui contenuti, lo scrittore per conto terzi deve arrangiarsi da solo. Pescando dalla propria informazione, nella propria cultura e nel proprio buonsenso. Può anche rivolgersi a un Ufficio studi, che dentro l'azienda e dietro l'imprenditore c'è sempre.
L'Ufficio studi fornisce dei materiali specialistici che, opportunamente rimasticati, possono essere fatti digerire a chi ascolta. Ci fu un periodo nel quale ritenevo che qualche citazione colta abbellisse il discorso, ne alzasse il tono. Mi resi presto conto che si trattava di un genere inflazionato. Elena Spagnol aveva scritto Il dizionario delle citazioni, elencandole per argomenti ed autore. Meglio, quindi, lasciarle a Enzo Biagi. Quando, nei primi anni '70, finii dentro questo mestiere gli industriali avevano cominciato a parlare in pubblico. A differenza del passato, quando le loro sortite erano riservate ai Consigli di amministrazione e alle assemblee. Con alle spalle i molti Nori che scrivevano per loro, si esibirono nei panni di economisti, storici, filosofi, esperti d'arte. In una assemblea, un azionista chiese all'amministratore delegato quando trovava il tempo di occuparsi dell'azienda, vista la frequenza con cui si esibiva in pubblico.
Non era la vanità a spingere gli imprenditori al travestimento. E neppure gli afflati culturali. Non ho mai pensato che gli industriali, visti come categoria, fossero detentori di una loro cultura: come la intende un intellettuale gravido di libri letti. Non ne hanno neppure bisogno. Goffredo Parise disegna il magistrale ritratto di un imprenditore che aveva successo ed era analfabeta. La cultura degli industriali è quella del loro mestiere. Come il ciabattino ha la cultura del deschetto e della lesina. Come gli indios degli altopiani del Messico, hanno la cultura di coltivare infinite specie di fagioli.
Eppure, sono gli atti degli industriali che hanno modellato la società in cui viviamo. Ma essi non sono capaci di vedere i risultati complessivi del loro agire. Della società che li circonda colgono, di volta in volta, solo gli aspetti che influenzano la loro impresa. L'impresa, inevitabilmente, è la misura di tutto. Per un industriale, diventa spesso una sorta di "corpo mistico". Quello che spingeva gli industriali a vestire panni diversi dal loro mestiere era il bisogno di accreditarsi, di trovare legittimità presso un'opinione pubblica che sentivano ostile. Il micidiale connubio fra cultura marxista e frange di cultura cattolica ha reso in Italia la figura dell'imprenditore oggetto di sospetto, quando non di ripulsa.
Ma nel loro continuo parlare, nello sconfinare nei campi più diversi, gli imprenditori hanno sempre trascurato di affrontare un argomento fondamentale: quale modello di società proponevano al paese. L'imprenditore Silvio Berlusconi, con il suo populismo tecnocratico, lo ha fatto; misurandosi con i sentimenti anti - industriali che ancora permeano il paese. Ha vinto la scommessa, è diventato Presidente del Consiglio. Se quello che ha promesso è soltanto la carta acchiappamosche di un'illusione, sarà il futuro a stabilirlo. Con il tempo, la frequentazione di clienti illustri e qualche intervista ai giornali mi guadagnai immeritata buona fama. Il mio mercato andò ben oltre i confini del mondo imprenditoriale.
Lavorai per decine di clienti, stanziali o occasionali. Approdai anche al mondo della politica: luogo di contorcimenti verbali, dove il parlare chiaro poteva risultare pericolosissimo. Lavorai per un giovane Presidente del Consiglio, morto prematuramente. Cercai di portare un contributo di chiarezza. Lui leggeva disciplinatamente i discorsi che gli scrivevo, anche se era convinto che a contare fossero i fatti non le parole. I fatti della politica fecero sì che le correnti del suo partito se lo mangiassero ben presto vivo.
Sono sempre stato una persona disponibile. Troppo giovane per partecipare alla guerra, troppo vecchio per tuffarmi nel '68: non ebbi ricordi condizionanti. Il lungo periodo vissuto immerso negli spiriti anarchici di Carrara, la mia città d'origine, mi aveva vaccinato dalle passioni ideologiche e politiche. Eppure, non ho mai scritto nulla che mi ripugnasse. Ho scritto molte cose a cui non credevo, ma che mi sembravano adatte a chi le avrebbe pronunciate.
Guardandomi indietro, mi rendo conto di avere trascorso una parte della vita facendo giochi di parole. Cercando di rendere il parlare meno stanco e l'ovvio meno banale. Forse, avrò anche scritto qualche discorso piacevole da ascoltare. Ma credo che nessuno dei miei discorsi abbia modificato la mentalità di chi lo pronunciava, o abbia influito sul corso delle cose.
Un discorso dura in tempo in cui viene pronunciato. Salvo eccezioni, naturalmente. Ma le eccezioni sono rare. E, nell'epoca della comunicazione globale, tutti parlano troppo. Il rumore è assordante, si perde la capacità di capire. Per ritrovare un po' di silenzio bisognerebbe ritornare a L'arte di tacere del settecentesco abate Dinouart. "E' bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio".
(Articolo di Enrico Nori tratto dai saggi di "Industria e Cultura", periodico dell'Unione Industriale di Torino, febbraio 2001, direzione Cesare Annibaldi e Giuseppe Berta, editore "Il Mulino).
Nelle foto: due immagini di Nori, una di Agnelli e la caricatura di Enrico Nori disegnata dall'artista Cherubino Binelli.