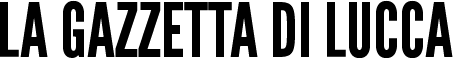Proviamo ad ampliare il concetto elaborato dal filosofo materialista tedesco, Ludwig Feuerbach (1804 – 1872) alla metà esatta del XIX secolo: Der Mensch ist, was er isst, ovvero “l’uomo è ciò che mangia”. Quindi, noi, oggi, siamo non solo quello di cui ci cibiamo, ma anche quello di cui si sono nutriti i nostri padri, i loro genitori, i genitori dei nostri nonni… E così via via, risalendo il corso delle correnti generazionali proprie di questi territori, un’immagine ben espressa poeticamente da Giuseppe Ungaretti nella strofa di uno dei suoi testi più noti e intensi, I fiumi:
Questo è il Serchio
al quale hanno attinto
duemil’anni forse
di gente mia campagnola
e mio padre e mia madre
Com’era, dunque, la cucina di questa gente mia campagnola?
Cucina povera, quella lucchese. Figlia di un mondo contadino, fondato sulla piccola proprietà e la famiglia numerosa che la coltivava. Il cibo e la sua preparazione erano un territorio retto da un potere assoluto e per niente democratico, quello della massaia. Era lei, in genere la moglie del capofamiglia ma non sempre, la reggitrice del governo della casa. Tra i suoi numerosi compiti atti ad assicurare il modesto benessere domestico, quello di riunire la sera intorno al desco tante e tante bocche, adulte e bambine, giustamente affamate dopo una giornata di duro lavoro nei campi. E la sua cucina doveva essere economica, senza sprechi e capace di utilizzare e riutilizzare, fatta di pietanze genuine, semplici e gustose che seguivano la stagionalità; soprattutto doveva risultare di soddisfazione per il palato dei commensali, forse rozzo, ma comunque esigente. Stomaci forti, quelli dei Lucchesi di campagna, usi a nutrirsi, come gran parte dei Toscani, di zuppe e minestre vegetali, cibi non ricercati, ma di sicuro idonei a riempire la pancia e garantire la quotidiana sopravvivenza. E, realizzarli, non era neppure troppo indaginoso. Bastava prendere la via dell’orto, in genere curato amorevolmente dall’intera famiglia, ed esso ti offriva ogni bendidio di prodotti: porri, fagioli e fagiolini, carote, agli e sedani, pomodori, carciofi, patate, cardoni, rape, cavoli e braschette, zucchine, erbi, barbe di frate… Per piatti solo di rado impreziositi da un pezzo di salsiccia, una fetta di lardo, una “coppia d’ova”. Sobrie abitudini alimentari che, però, fin dal tempo dell’apparire da queste parti delle legioni romane, gli abitatori delle Lucchesia hanno saputo connotare in maniera originale.
Antico, umile, resiliente: il farro.
Stiamo parlando del farro. Mangiandolo, vi cibate del più antico tipo di frumento coltivato, utilizzato come nutrimento dalla specie umana fin da tempi così remoti che la storia non era ancora cominciata, o meglio gli uomini non avevano ancora iniziato a raccontarla. Poi - si narra - la dea Demetra lo regalò all’umanità e, da allora, per secoli, per millenni, il farro e i bipedi sapienti andarono d’amore e d’accordo. Nella Roma arcaica, una focaccia di farro spezzata in due sanciva solennemente l’unione matrimoniale tra un uomo e una donna. Un millennio più tardi, Ildegarda di Bingen, mistica, poetessa, asceta e guaritrice definì la nostra graminacea “medicina universale” in virtù delle sue innumerevoli proprietà terapeutiche. Oggi, dopo che quell’antica alleanza si è progressivamente allentata, l’uomo europeo riscopre il farro, al quale, a ragione, potrebbe applicarsi un aggettivo divenuto di moda: resiliente. Ovvero, capace di fare fronte alle difficoltà, uscendone rafforzato. Infatti, questo frumento si adatta ai terreni poveri e non teme le basse temperature; il suo chicco, poi, duro e compatto, tiene lontano i parassiti e, di conseguenza, i veleni fertilizzanti e diserbanti. Ê, insomma, un cereale biologico per natura.
Dal farro, dunque, è giunta all’uomo una ricca cornucopia di doni… Ma, come spesso accade ai buoni, agli umili, ai pazienti, è stato, a poco a poco, dimenticato e soppiantato da coltivazioni in grado di garantire una maggiore produttività e una più cospicua resa economica. Da un trentennio a questa parte, però, questo frumento, forte solo delle sue modeste virtù, sta conoscendo una rinnovata attenzione da parte di tutti quei consumatori che amano un mangiare semplice e sano. Schietto, come le genti d’Umbria e di Toscana - segnatamente la Garfagnana - che la sua coltura non l’hanno mai dismessa.