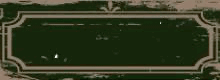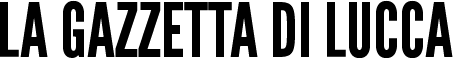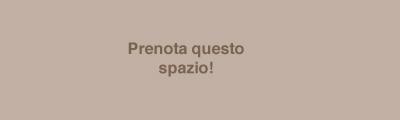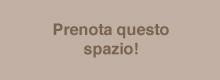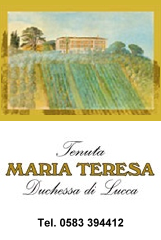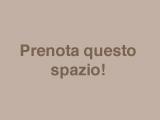Alla vigilia dell’ennesima edizione del Festival di San Remo non risulterà certo inopportuna una veloce rassegna di alcuni momenti di storia della canzone italiana, per aiutare a capire meglio, anche attraverso le canzonette, chi siamo e da dove veniamo.
Prendiamo per esempio gli anni Trenta. Il fascismo è ormai un regime ampiamente consolidato. Nelle elezioni di un anno prima, in maniera plebiscitaria, la quasi totalità degli italiani gli ha dato il proprio assenso. Nel Paese procede a grandi passi la militarizzazione dell’economia e della società. Viene dichiarata guerra all’Etiopia. La Società delle Nazioni – l’Onu di allora – decide di applicare all’Italia sanzioni economiche che sono sfruttate per mobilitare l’opinione pubblica e lanciare la “campagna per l’oro alla patria”, a conclusione della quale vengono raccolte milioni di fedi nuziali. Ad andare controcorrente, nella palude del conformismo dominante, sono veramente in pochi: qualche gruppo operaio, alcuni intellettuali…
A maggio, a Torino, nel corso di una retata vengono tratti in arresto Giulio Einaudi, Cesare Pavese, Carlo Levi, Norberto Bobbio.
Disimpegnate ed evasive le passioni degli italiani negli anni Trenta: il cinema, finalmente arricchito del sonoro e, manco a dirlo, la canzonetta. Quando poi il primo si intreccia con la seconda, il successo è assicurato.
È il caso di Non ti scordar di me, un film, di cui, nella memoria cinematografica, non sarebbe forse rimasta traccia, se non fosse stato per l’omonima canzone, interpretata nientemeno che da Beniamino Gigli, attore goffo, ma tenore grandissimo per dolcezza di timbro e cordialità di espressione.
La radio, altra grande passione italica di quegli anni, moltiplica questo successo, lo amplifica, lo porta in un milione e mezzo di famiglie: tanti gli apparecchi radio in Italia alla fine di quel decennio.
Parole e musica degli anni Trenta.
Alfredo Bracchi e Giovanni D’Anzi rappresentano una coppia destinata a durare alcuni decenni nella storia della canzone italiana.
Tutti e due appartengono al mondo del palcoscenico e dell’intrattenimento leggero e a loro si deve se la canzone milanese recupera posizioni e importanza rispetto a quella napoletana e romana.
Di Giovanni D’Anzi è la celeberrima Madonina, di entrambi l’accorata Nostalgia de Milan, scritte nel 1938. Ma la canzone in vernacolo stava loro stretta e produssero quindi in lingua motivi e testi indimenticabili: Bambina innamorata (1934), Ma le gambe (1938), Signorina grandi firme (1938), interpretate dal Trio Lescano; Non sei più la mia bambina (1938), Silenzioso slow (1940); Tu, musica divina (1940).
Non dimenticar le mie parole è del 1937 ed è un esempio significativo di quello “stile Novecento”, che pervade tante canzonette della seconda metà degli anni Trenta: flessuose, languide e ben ritmate…
Le prosperose campagnole…
“All’alba, quando spunta il sole, / là nell’Abruzzo tutto d’or… / le prosperose campagnole / discendono le valli in fior… / o campagnola bella, / tu sei la reginella;
negli occhi tuoi c’è il sole, / c’è il colore delle viole, / delle valli tutte in fior!... / Se canti la tua voce / è un’armonia di pace, / che si diffonde e dice: / se vuoi essere felice, / devi vivere quassù!...
Ritorno di una modesta e attardata sensibilità arcadica o anticipazione di tematiche verdi/ambientaliste?
Né l’uno né l’altro caso: piuttosto l’allineamento disciplinato degli autori di canzonette alle direttive del regime, impegnato non solo nella battaglia del grano, nella bonifica delle paludi pontine, nell’autarchia… Ma anche nella moralizzazione di un costume che tendeva ad americanizzarsi e, quindi, agli occhi del regime e del Capo, a corrompersi.
In polemica con lo swing e con il jazz, criminalizzate come “musiche da negri”, e con tutte le mode d’oltreoceano, giudicate corrosive del sano costume nazionale, i testi delle canzoni si riempiono di prosperose paesanelle, di Rosabelle molisane, di strade nel bosco, di pastorelli innamorati, sicuri baluardi italici di laboriosità e moralità.
Dio, patria e famiglia, insidiati nelle città, sempre perdute e tentacolari per gli autori delle canzonette d’epoca, si prendono in campagna una sonora rivincita.
Lo scandaloso Maramao
Di “Maramao… perché sei morto” è autore il prolificissimo Mario Panzeri, che sarà accusato di avere alluso alla recente dipartita, 1939, di uno dei big del regime, quel Costanzo Ciano il cui monumento funebre, in pretto stile assiro-babilonese, incombe, ancora adesso, sul mare di Livorno.
A portare al successo la triste storia in versione swing di Maramao, aristogatto del 1939, saranno le sorelle olandesi, ex acrobate, Sandra, Giuditta e Caterinetta Leschan, che italianizzeranno il cognome in Lescano.
Un trio destinato a fare epoca: bruttine anzichenò, le sorelline debbono il loro successo non certo all’aspetto fisico, ma a un formidabile senso del ritmo, all’accento esotico – a metà tra il mitteleuropeo e l’inglese – e alla radio.