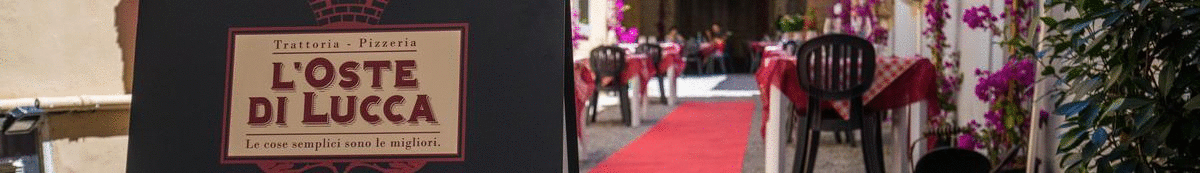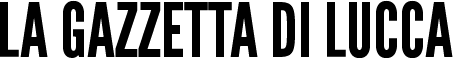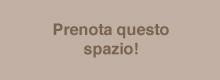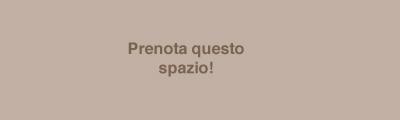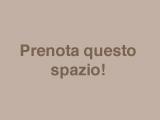È lungo, lunghissimo, il comunicato ufficiale con cui la sezione lucchese di LAV (Lega anti vivisezione lucchese) si è scagliata contro le ultime decisioni prese da Coldiretti, ma anche da Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition, in merito ad un possibile supporto e valorizzazione della cosiddetta “clean meat” o carne coltivata.
La questione della carne coltivata sta pian piano facendosi spazio all’interno del dibattito nazionale, esemplare il servizio proposto da Report su Rai3, ma sembra che ai piani alti del comparto agroalimentare facciano orecchie da mercante: il “made in Italy” è un qualcosa di troppo prezioso per essere messo in discussione.
Quelli di LAV però non sentono storie, e si vede vista la carrellata di citazioni di frasi celebri e accenni di studi scientifici: per loro l’idea di un prodotto fatto in laboratorio non solo è etico, ma avrà un impatto infinitesimale sulla salute del pianeta rispetto a quello che oggi ha l’allevamento intensivo.
Meno uccisioni animali, meno inquinamento, più spazio per colture e habitat per altri animali: LAV, per bocca della presidente di sezione Chiara Testi e dell’attivista volontaria Elena Franceschini, vede nella carne coltivata una scommessa in cui è impossibile perdere.
Un motivo in più per esternare tutta la loro insoddisfazione riguardo ai commenti dati da Coldiretti e soci, etichettate come ascientifiche e legate ad interessi economici.
“In questi ultimi giorni alcuni esponenti politici dei vari schieramenti, addetti al settore agricolo e non solo, si sono dichiarati apertamente “anti-scienza”. Se fino a qualche mese fa la maggior parte di loro aveva dimostrato una fiducia cieca nella ricerca scientifica, oggi sembra essere calato un velo di sfiducia e scetticismo. A lanciare la sfida alla cosiddetta “clean meat”, o carne coltivata (e non “sintetica” come erroneamente viene definita da chi dovrebbe dare informazioni corrette alla popolazione), è “Coldiretti”, insieme a Fondazione “Campagna Amica”, “Filiera Italia” e “World Farmers Markets Coalition”. Quello delle alternative all’allevamento e alla macellazione di animali è un tema tanto complesso quanto importante, che riguarda il futuro del pianeta e delle nuove generazioni. “Sfuggiremo all’assurdità di far crescere un pollo intero, solo per mangiarne delle parti, facendo crescere quei pezzi in un ambiente adatto”, aveva predetto Winston Churchill. A prescindere dal fatto di essere favorevoli o meno a tali prodotti innovativi, dovremmo prima di tutto chiederci perché si sta investendo molto su nuovi sistemi di produzione alimentare, in particolare sui sostituti di quelli di origine
animale. La prima riflessione da fare però è quella che porta a chiederci se gli animali possono soffrire, come già affermava il filosofo e giurista Jeremy Bentham nei secoli scorsi, per decidere di liberarli dal dolore e dalla morte. L’ “Oxford Centre for Animal Ethics”, ed i principali Istituti di ricerca, ci confermano che essi sono capaci di costruire relazioni, sentire emozioni, provare sentimenti. Il tempo della concezione cartesiana dell’animale-macchina è ormai superato: gli animali sono esseri senzienti, individui cui garantire benessere e diritti, e non “cose” a nostra disposizione. “Verrà un giorno in cui guarderemo all’uccisione degli animali nello stesso modo in cui oggi si guarda a quella delle persone”: così Leonardo da Vinci. Chissà se quel giorno non si stia avvicinando. Sulla base della dichiarazione di Cambridge sulla coscienza degli animali non umani, le legislazioni di tutto il mondo, derivanti dal diritto romano, stanno modificandosi in base agli “Animal Rights”. “La “carne coltivata” ferma la crudeltà nei confronti degli animali, è migliore per l’ambiente, può essere più sicura, efficiente e salutare. Abbiamo l’obbligo morale di supportarla”, così il bioeticista australiano Julian Savulescu. Sorprende dunque la generale levata di scudi proprio da parte di chi dovrebbe stare dalla parte della pace, della giustizia e delle pratiche non cruente. Luca Lo Sapio, bioeticista italiano, ha evidenziato l’impatto positivo che questa tecnologia può avere sulla biosfera, sulla salute umana e sul benessere animale. Un tipo di ricerca da monitorare e valutare con occhio critico, considerando rischi e benefici, ma non da contrastare in toto. Non si dovrebbero fomentare reazioni tecnofobiche ed oscurantiste, evocando paure ancestrali. Tralasciando gli aspetti filosofici ed etici, ci concentriamo qui su quelli ecologici ed ambientali Secondo dati ISTAT, in Italia nel 2019 sono stati macellati 11.481.326 suini, 2.624.815 bovini, 511.764.000 polli, 16.573.000 conigli, 2.810.435 ovini. Si parla di circa 150 miliardi di animali all’anno a livello globale, esclusi i pesci. Un massacro sistematico, massivo, innecessario. Le immagini pubblicitarie ideali e bucoliche di animali liberi di pascolare in prati verdi rappresentano, purtroppo, solo una percentuale esigua degli allevamenti, anche per quanto riguarda quelli italiani: il 93,3% degli allevamenti di bovini, il 99,3% di quelli suini e il 99,3% degli avicoli sono intensivi, mentre il 55% delle galline ovaiole vive in gabbia. La chimica e la genetica sono ormai da decenni utilizzate nel cosiddetto “cibo naturale”, in tutte le fasi della filiera. Secondo il Gruppo Intergovernativo di Esperti sul Cambiamento Climatico (IPCC), l’attuale sistema zootecnico contribuisce in modo significativo
all’esaurimento e all’inquinamento di risorse primarie come l’acqua, all’immissione in atmosfera di gas serra ed è imputato nella deforestazione degli ultimi polmoni verdi del globo. Il 60% dei mammiferi a livello mondiale è costituito da animali allevati, il 36% rappresenta gli esseri umani, mentre solo il 4% riguarda i selvatici. Il 70% degli uccelli è allevato, solo il 30% è selvatico. Un disequilibrio ecosistemico senza precedenti, che mette a rischio la sopravvivenza stessa dei “sapiens”, in larga parte causato dal tipo di alimentazione che scegliamo ogni giorno, più volte al giorno. Ciò che mettiamo nel piatto è dunque un atto politico e collettivo, che può cambiare il destino del mondo. Per ottenere un burger di carne animale sono necessari 1700 litri d’acqua, 270 litri per un hot dog; l’85% delle emissioni nel settore alimentare riguarda cibi
di origine animale. “Our World in Data” mostra che per gli animali destinati a diventare “carne” sono necessari 2.89 miliardi di ettari di terreno e 538 milioni di ettari per produrre il loro cibo; il 70% della superficie agricola dell’Unione Europea è destinata alla coltivazione di mangime e foraggio per gli animali, invece che a diventare cibo per le persone. Si trova cibo ed acqua per un numero esorbitante di bovini, suini, polli ed altre specie, ma non per nutrire i quasi dieci miliardi di persone che popoleranno il pianeta tra qualche anno. Nel mondo, 800 milioni di esseri umani soffrono la fame, poiché un’ampia parte del terreno coltivabile è destinato a far crescere foraggio per gli animali che diventeranno “carne”, il cui “indice di conversione” (IC) non è efficiente. Ricercatori di Oxford ed Amsterdam hanno rilevato che la produzione di carne coltivata ridurrebbe i consumi energetici del 45%,, richiedendo solo il 2% di tutte le terre utilizzate per l’industria dell’allevamento, con emissioni di gas serra nettamente inferiori. Scegliere un tipo di alimentazione “plant based” (a base vegetale) è quello che potremmo e dovremmo decidere di fare per il pianeta e i suoi abitanti. Secondo studi condotti da Walter Willett, professore presso la Harvard School of Public Health, entro il 2050 i sistemi alimentari mondiali dovranno radicalmente cambiare verso una dieta a base vegetale. Ormai sulla sicurezza ed i benefici delle proteine vegetali, sia a livello nutrizionale che salutistico, si sono espressi favorevolmente i “position paper” e gli studi in “peer review” delle principali accademie scientifiche di nutrizione umana. Non possiamo tralasciare di evidenziare, inoltre, come i “nostri” politici, sia a livello nazionale che locale, non abbiano mai davvero informato la
popolazione circa il rischio zoonosi che gli allevamenti di animali comportano, come invece avrebbero dovuto fare. L’occasione che ogni situazione di crisi porta con sé non è stata colta, e cioè quella di adottare stili di vita nuovi e sostenibili. “Non torniamo come prima” è stata la campagna di LAV in tempo di pandemia, promossa attraverso “flash mob” in tutta Italia: iniziativa che tendeva ad informare la cittadinanza sui comportamenti che mirano alla prevenzione di future zoonosi. La pandemia da Covid-19, che pian piano ci stiamo lasciando alle spalle e che tanto dolore ha causato, avrebbe dovuto insegnarci qualcosa, in primis a rispettare il principio di precauzione. Invece di fomentare paure ancestrali evocando l’incombere di un cibo “sintetico”, non a caso viene utilizzata una terminologia fuorviante, bisognerebbe sottolineare come non sia naturale nemmeno allevare animali selezionati artificialmente, come i suini “large white” o i polli “broiler”; non è naturale ammassarli a migliaia in capannoni saturi di ammoniaca, senza la possibilità di vedere la luce del sole per tutta la loro vita ed alimentarli anche con prodotti OGM. Non è naturale detenerli in luoghi fetidi e bui e non curare gli animali malati lasciandoli morire tra quelli vivi, sommersi da topi e sporcizia; non è naturale immobilizzare le scrofe nelle gabbie di contenimento per tutta la vita, ingrassare polli fino a renderli deformi e con gli arti spezzati a causa del loro petto sproporzionato; non è naturale separare i vitelli appena nati dalle loro madri, per chiuderli in piccoli box se femmine ed ucciderli se maschi; non è naturale legare a catena le vacche ed ingravidarle artificialmente per farle diventare macchine da latte; non è naturale triturare vivi pulcini maschi perché inutili all’industria. Come sostiene il filosofo pioniere dei diritti animali Peter Singer, a causa di quella parte di società “carnista” è oggi più che mai necessario trovare delle alternative allo sfruttamento di corpi di animali, di territori e popolazioni del sud del mondo; dovremmo cercare di approfondire, capire e conoscere, piuttosto che demonizzare in nome di una tradizione che fa parte di un immaginario ideale, ma anacronistico e spesso distorto. Adesso possiamo provare ad immaginare laboratori con le pareti di vetro, molti diversi dai mattatoi, concepiti ed organizzati lontani dalla nostra vista e dai nostri più cupi pensieri. La società evolve e l’alimentazione segue il passo del cambiamento. Ricordiamo come gli spaghetti, diffusi dal 1700, non furono visti di buon occhio per decenni. Erano infatti considerati un alimento esotico, troppo lontano dalla tradizione culinaria dell’epoca. Si trattava infatti di una pasta allungata, proveniente dall’oriente, condita con del pomodoro, importato dalle Americhe. Oggi sono uno dei simboli dell’italianità e del “made in Italy”.
Commento del direttore (ir)responsabile: la carne sintetica la devono mangiare quelli della Lav se proprio ci tengono. Noi continuiamo ad amare le nostre belle bistecche e i nostri polli allevati, se possibile, come Cristo comanda. Un conto è la lotta alla vivisezione e ad altre pratiche barbare di sfruttamento degli animali, pienamente condivisibili come lo era agli inizi della vita della Lav, altro è appoggiare la carne in laboratorio, una assurdità al pari di tante altre di un mondo che va sempre peggio. Infine una preghiera: scrivete di meno altrimenti la prox volta un comunicato così lungo o ve lo redazionate da voi o non lo pubblichiamo.