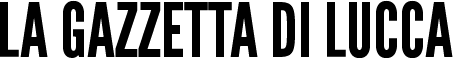Fin dai loro esordi le letterature, tutte le letterature, si sono trovate a dover fare i conti con la società, la storia, la politica, la religione… Insomma, il potere. In quella italiana, Dante, guelfo ma bianco, più orientato verso l’imperatore che verso il papa, che ribadisce più e più volte questa sua appartenenza, rappresenta l’esempio più alto di un intellettuale impegnato a promuovere un suo un progetto di città per gli uomini.
Ma già i letterati della generazione successiva a quella di Dante, Petrarca per esempio, mutarono il punto di vista, preferendo una letteratura fine a se stessa, autosufficiente e sempre più priva di interessi storici, politici, sociali… I secoli che seguirono furono un tempo di assoggettamento politico: allo splendore delle arti, corrispondeva una sempre più organica subalternità del nostro Paese nei confronti dei soggetti forti della storia europea e mondiale, mentre gli intellettuali, in primis i letterati, erano costretti a rifugiarsi in ruoli di tipo cortigiano. I soli in cui era possibile ritagliarsi modesti, modestissimi spazi di una libertà sempre precaria, sempre insidiata. Prevalse, allora, la pratica della “dissimulazione onesta”. Ovvero, un barcamenarsi tra verità e falsità, dire e non dire, accennare soltanto, non denunciare mai le cose come sono, offrendo così “qualche riposo al vero”, per affermarlo più tardi, quando - e se - ce ne saranno le condizioni adatte. Una prassi, uno stile intellettuale che durerà sino al Foscolo, sino alle battaglie risorgimentali. Quando il modello dell’intellettuale “puro” entrerà in crisi e poeti, letterati, scrittori si coinvolgeranno con pienezza nelle lotte per l’unità italiana.
Di gran lunga modesti, però, a parte qualche eccezione, gli esiti letterari di tale nuovo atteggiamento. Già, chi legge più oggi il Guerrazzi o il D’Azeglio, il Mercantini o il Fusinato? Dunque, quanto più un letterato si cala con i suoi strumenti nella pancia profonda della storia, pensando di poterne interpretare ragioni e sentimenti, tanto più le sue pagine si fanno contingenti e occasionali? Perché gli autori più grandi del nostro Ottocento, dico Leopardi e il Belli, mantengono un profilo defilato, appartato, periferico rispetto alla letteratura del loro tempo - quella degli “eroici furori” risorgimentali - quando, addirittura, non appaiono ostili ai grandi temi patriottici, nazionali, ottimistici di quel periodo? Arte e politica, dunque, arte e impegno civile, si escludono vicendevolmente? Quale, insomma, il ruolo dell’intellettuale, e segnatamente del letterato, nel proprio tempo, nel segmento di storia e di società che gli è stato assegnato? Quale il suo compito “civile”, se pure deve averne uno?
Accostiamoci ora al Novecento al “secolo breve”. Che cosa vediamo? La nascita e il proliferare delle avanguardie letterarie e il loro precipitare, tutte e di tutti i Paesi, nella “inutile strage” del primo conflitto mondiale. Poi, gli anni delle dittature che ora troveranno i loro più significativi corifei proprio negli intellettuali letterati, ora di questi conosceranno al più l’appartarsi complice o il silenzio rinunciatario.
Negli anni successivi alle catastrofi della seconda conflagrazione mondiale, il problema del rapporto tra letteratura e politica, tra letteratura e le ideologie che per quasi mezzo secolo hanno diviso il mondo, tornò a riproporsi con ancora maggiore acutezza. L’intellettuale, lo scrittore, il letterato - se è giusto, se è lecito schierarsi - da quale parte deve farlo? Con chi è necessario allearsi? In Italia e in Francia, nel clima ancora fervido della vicenda resistenziale, prevalse l’idea dell’intellettuale, la cui funzione era quella di un uomo di cultura attivo, “impegnato”, non isolato nella sua torre d’avorio, ma disponibile, sempre e comunque, a battersi per migliorare la società ed eliminarne i difetti e le ingiustizie. Non pochi giovani scrittori, allora, provati dalle esperienze della guerra, della prigionia, della Resistenza, delle durezze degli anni della ricostruzione, sentirono il bisogno di recuperare la realtà sociale e tali argomenti diventarono spesso, forse troppo spesso, occasioni narrative affidate prevalentemente al romanzo. Il letterato si politicizzava in forme e manifestazioni non di rado eccessive che finivano per dare vita a distinguo, polemiche, ripensamenti… Una risposta al quesito, sempre riproponentesi, del corretto rapporto tra intellettuali e politica ci venne dalla Germania, la nazione che più di ogni altra aveva contribuito a scatenare il conflitto che aveva determinato il disastro dell’Europa, ridotta, all’indomani del ’45, a un largo “Paese selvaggio”, privo di regole, di leggi, scenario di vendette e rappresaglie. Proprio dalla Germania, che ha pagato, e duramente, le conseguenze del delirio nazista, è emersa a mio parere l’indicazione più semplice e più limpida del corretto posizionamento dell’intellettuale, del letterato, del poeta riguardo al proprio tempo storico. Ce la fornisce un romanziere tedesco, cattolico e pacifista eppure soldato nel secondo conflitto mondiale, quattro volte ferito in guerra, nel 1972 premio Nobel per la letteratura. Si chiama Heinrich Boll e proprio nell’anno del suo massimo riconoscimento mondiale, dà alle stampe uno smilzo libretto di versi, Gedichte (Poesie). Qui il lettore può incontrare in un testo brevissimo, un monito agli intellettuali del suo tempo circa la funzione civile della letteratura, l’unica che competa loro: “Da’ l’allarme / raduna i tuoi amici / non / quando urlano le iene / non / quando ti gira intorno lo sciacallo / o quando / abbaiano i cani da guardia / non / quando il bue aggiogato / fa un passo falso / o il mulo inciampa all’argano / da’ l’allarme / raduna i tuoi amici / quando i conigli mostrano i denti / rivelando la loro ferocia / quando i passeri scendono all’attacco / in picchiata / Da’ l’allarme” .