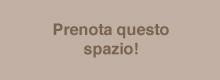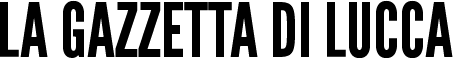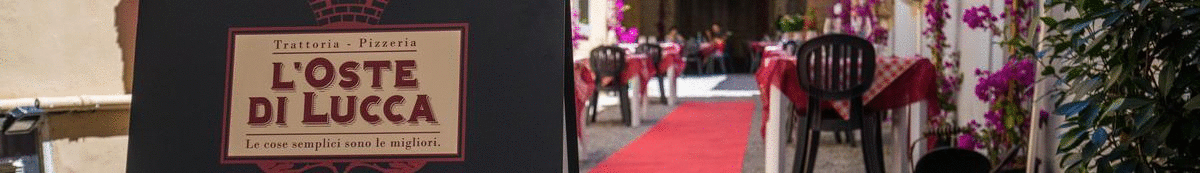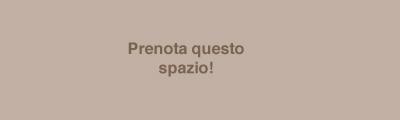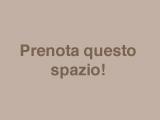C’è troppo cibo nelle nostre vite: ne siamo addirittura sommersi! Non solo quello di cui ci alimentiamo per soddisfare le normali necessità fisiologiche, ma cibo che si è fatto libro, cinema, televisione, social- media… Casalinghe e chef pluristellati, massaie e pizzaioli, rosticcieri/e e pasticceri/e, ormai non ti salvi, cucinano in diretta televisiva a tutte le ore del giorno e della notte; i libri di cucina coprono metri e metri di scaffali nelle librerie e il cibo è l’argomento principe di non pochi, anzi troppi, film che trattano l’argomento in tutte le sue varianti, di solito privilegiando il gastro-erotismo… E qualche giornale ci racconta anche delle sempre più frequenti incursioni in cucina di scienziati di chiara fama, fisici e chimici, che non disdegnano di dedicare il loro tempo prezioso ai modi per la realizzazione di una scientificamente perfetta “cacio e pepe”. All’università di Parma, ci dicono, pare sia anche stato inaugurato un Laboratorio di Gastrofisica: insomma, da alcuni anni a questa parte, i rapporti tra scienziati e chef si sono fatti via via più intensi e percorsi e ripercorsi nei due sensi. Non ho potuto quindi fare a meno di apprezzare per discrezione, misura e intelligenza questo piccolo libro a chilometro zero, edito dalla benemerita Associazione Ponte, Ricette dei nostri tempi. Usate in famiglia agli inizi del terzo millennio, scritto a quattro mani da Luciano Fanucchi, capannorese doc, e sua moglie Christiane Henneau, che, come rivelano il nome e il cognome della Signora, di origini lucchesi proprio non dovrebbe essere. Una condizione questa che permette ai nostri due autori di arricchire le proposte gastronomiche fondate sulla tradizione toscana locale con sapori, profumi, colori del tutto nuovi. Così, accanto alle ricette di piatti di una cucina toscana senza sprechi, capace di utilizzare e riutilizzare, fatta di pietanze genuine, semplici e gustose che seguono la stagionalità, e di soddisfazione per il palato dei commensali, forse rozzo ma comunque esigente, ne compaiono altre, le cui origini rimandano a una più larga area, mediterranea e non solo, che va dal Maghreb alla Sicilia, dalla Catalogna su su fino alla Normandia… Una contaminazione testimoniata dalla presenza di ricette tipiche della cucina francese come la Sole à la meunière (Sogliola alla mugnaia) oppure dalle Coquilles Saint Jacques alla normanda (Capesante), o anche dall’utilizzo ribadito della melanzana o della semola di grano duro cotta al vapore… Piatti che sembrano convivere benissimo col tordello lucchese, con le zuppe toscane, con le torte paesane. Una contaminazione, certo, un’ibridazione, ma chi ti dice che sia un male? Tutta la storia della cucina risponde a questa tensione, a questo movimento. Anche le ricette che si tramandano di madre in figlia all’interno del desco familiare, a pensarci bene, sono sottoposte a tale incessante lavorio di mutamenti, di variazioni. Risentono, e non se ne può fare a meno, del contesto sociale e culturale tutt’attorno. Oggi viviamo in un’epoca in cui, grazie ai nuovi, formidabili mezzi di comunicazione, si diffondono su scala planetaria tendenze, gusti, idee, problematiche… È la globalizzazione, bellezza, e, anche in cucina, nessuno di noi può imporre alla ruota della storia di girare al contrario.
Luciano Fanucchi – Christiane Henneau, Ricette dei nostri tempi. Usate in famiglia agli inizi del terzo millennio, Associazione Culturale Ponte, Capannori 2024, pp. 72, sip